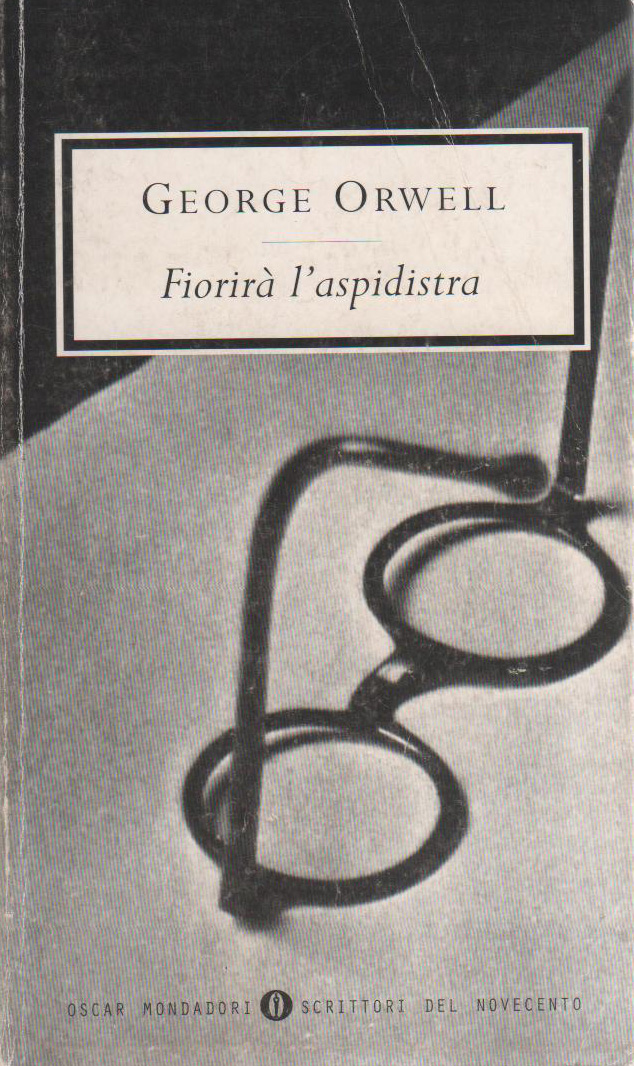Fra tutti i tipi dell'essere umano, soltanto l'artista si assume la responsabilità di dire che "non può" lavorare. Ma è verissimo; ci sono momenti in cui non si può lavorare. Ancora i quattrini, sempre i quattrini! La mancanza di quattrini diventa disagio fisico e morale, significa squallide preoccupazioni, significa mancanza di tabacco, significa coscienza onnipresente del proprio fallimento, soprattutto significa solitudine. Che altro puoi essere se non un povero diavolo tutto solo con due sterline alla settimana? E in una solitudine di tanta tristezza non si potrà mai scrivere un libro degno di questo nome.
Ci sono libri che leggi in un momento particolare della tua vita, particolarmente da giovane, e ti restano dentro per qualche motivo che sai solo tu, e che anzi troveresti parecchio complicato da spiegare a qualcun altro. Sai solo che, in un angolo della tua testa, quel libro è sempre vivo, nonostante tu cominci a dimenticarne qualche passaggio, o perfino personaggi interi. Rompi le scatole ad amici e conoscenti –leggilo, ti piacerà!- e non sai neanche tu più perché.
Ci sono libri che rileggi dopo tanto tempo. Alcuni reggono, e sai che sono dei classici (almeno per te). Altri, invece, risentono di quel tempo che è passato. Forse li hai idealizzati, forse eri giovane. Forse le cose che hai imparato nel frattempo hanno coperto quelle precedenti. Non le rende meno importanti, ma senti che il tempo è passato per tutti.
Così è stato per questa rilettura di “Fiorirà l’aspidistra” (Mondadori), romanzo meno conosciuto di George Orwell. E la cosa buffa è che potrei dirvi esattamente del momento in cui ho pescato per caso questo libro tra i classici dalla costa rossa della collezione di mio nonno, di quando ho cominciato a leggerlo senza poterne staccare gli occhi, delle riflessioni che quelle pagine avevano piantato nella mia testa da diciottenne. Eppure, rileggendo la storia, mi sono reso conto di come avessi dimenticato alcuni punti importanti della trama, fin quasi a stravolgerne il significato –o almeno, quello che ci avevo visto io. È strano realizzare come forziamo i vari pezzi nella nostra memoria, fino a farli coincidere con quello che vogliamo ricordare.
Venendo al libro, “Fiorirà l’aspidistra” segue le vicende di Gordon Comstock, libraio squattrinato e aspirante artista sull’orlo dei trent’anni. Presto veniamo a sapere che Comstock, cresciuto in una famiglia sulla soglia della povertà, aveva trascorso la sua giovinezza tra mille difficoltà economiche fin quando era stato assunto come copyrighter di un’agenzia di pubblicità. Era bravo nel suo lavoro, e finalmente aveva raggiunto una stabilità finanziaria mai conosciuta prima. Aveva persino conosciuto Rosemary, una ragazza con un background simile a quello di Gordon, che era diventata la sua compagna.
Tutto bene, insomma. A parte il fatto che Gordon si sentiva profondamente insoddisfatto. La sua aspirazione era quella di diventare uno scrittore, e sentiva che non sarebbe mai potuto succedere finché fosse rimasto a fare quel lavoro –ammaliato da una vita borghese e rassicurante che considerava velenosa per la sua ispirazione. Per questo motivo aveva deciso di licenziarsi all’improvviso, accettando un impiego senza pretese, con una paga minima, presso una libreria semi-deserta. Aveva pubblicato un libro di versi che era stato ben presto dimenticato e messo da parte insieme alle centinaia di tomi che prendevano polvere nella sua libreria. Passava così il suo tempo: di giorno si districava tra i pochissimi clienti, di notte tornava alla sua stanzetta solitaria e fredda per lavorare al poema che aveva iniziato anni prima, e che sperava un giorno di finire.
Col passare dei giorni, si rende conto che probabilmente quel poema non finirà mai, né diventerà uno scrittore famoso. Allo stesso tempo, Gordon non vuole tornare indietro. Nonostante debba risparmiare su ogni centesimo, a volte digiunando, è felice di non dover più sottostare a quello che lui chiama “il dio quattrino”. A niente valgono le preghiere di Rosemary (che lo ama ma teme per il loro futuro) o quelle di Ravelston, l’unico amico di Gordon, un ricco figlio di papà che cerca di guarire dal senso di colpa datogli dalla rendita che possiede, aiutando artisti sfortunati come Gordon.
Queste le premesse del libro, che seguirà le meditazioni (e le maledizioni) di Gordon, diviso tra lo sdegno per la propria povertà (nonostante sia stata scelta) e l’irrisione dei finti idoli che il consumismo andava già producendo a pieno ritmo.
Rileggendolo, il ritmo mi è sembrato decisamente più lento e ripetitivo di come lo ricordavo, così come avevo rimosso il fatto che Orwell renda Gordon uno di quei personaggi per i quali è quasi impossibile parteggiare. La sua ostinazione a volte è parossistica, tanto da farti incazzare, e purtroppo danneggia la possibilità di farne un antieroe. Questa, probabilmente, non era l’intenzione di Orwell fin dal principio, ma lo stesso il rischio è che tutte le istanze coraggiose di Gordon, come il rifiuto del posto fisso e la voglia di vivere da artista libero, vadano perse dietro l’antipatia che, pagina dopo pagina, rischia di svilupparsi verso questo personaggio.
La prosa di Orwell finisce spesso per reiterare alcuni concetti, appesantendo la lettura e rischiando di cancellare il messaggio.
Perché allora mi era piaciuto tanto, direte voi?
Forse proprio perché, come menzionato prima, l’ho letto a 18 anni –in quella fase della vita in cui sentivo già il peso degli obblighi che erano gli stessi che Rosemary e la famiglia impongono (senza imporli) a Gordon. L’idea stessa di trovarmi un lavoro, fare carriera e tutte quelle stronzate lì mi faceva rabbrividire. Di contrasto, l’idea di fare l’artista morto di fame non mi dispiaceva affatto.
Sì, mi sa che ero già fregato in partenza.
Anche se parecchio pivello, intuivo che di trappole ce ne sarebbero state parecchie. Per questo la storia di “Fiorirà l’aspidistra”, al di là di manierismi, retorica politica e qualche rallentamento, mi era piaciuto così tanto: affrontava il tema della libertà di scegliersi la vita che si vuole, senza farsi dominare dalle pressioni della società.
Che poi, rileggendolo, illustra proprio l’opposto (e non vado avanti per non fare troppo spoiler). Eppure Gordon mi piaceva, e mi piace. Forse l’idea dell’artista duro e puro, che non scende a compromessi, è ormai datata e più che abusata. Ma Orwell, che ha vissuto la povertà sulle sue ossa (a proposito, se potete leggete “Senza un soldo a Parigi e Londra”), ha il merito di spogliare questa idea di ogni romanticismo e dire quello che nessuno prima aveva detto: con la pancia vuota, anche l’ispirazione va a farsi fottere. Quello che suona poetico sulla carta, può ammazzarti poi se messo in atto.
Con uno sguardo realista e brutale, che non evita frecciate al “comodo” socialismo del ricco Ravelston (contrapposto all’incazzato nichilismo di Gordon), Orwell fa capire la difficoltà che si può incontrare ad andare “per la propria via”, e come può essere pericoloso porsi al di fuori della società.
Molti dei suoi temi sono più che attuali. Con la nostra fissazione per il posto fisso, quanti di noi lo mollerebbero, come ha fatto Gordon, per provare a realizzare dei sogni definiti da tutti impossibili e puerili?
Che poi il risultato non sia quello sperato, è un discorso diverso –importante, ma diverso. Gordon ha il coraggio di rompere con quel mondo, mandando affanculo il proprio lavoro (coronando il sogno di milioni di persone), e decidendo di vivere con pochissimo, con un rigore da monaco benedettino. Tutto, pur di non dover dipendere più da nessuno.
Ma è proprio così? Si può vivere liberi, senza dipendere da nessuno, facendo a meno dei soldi?
In tempi cinici e tosti come i nostri, la risposta è così scontata che il problema nemmeno si pone. Eppure, rileggere questo libro dimenticato di Orwell può aiutare a capire come siamo arrivati a questo. Quando abbiamo rinunciato ad essere quello che volevamo, per diventare quello che ci poteva fruttare di più.
Con tutto il peso degli anni che la sua prosa (non scorrevolissima) porta con sé, vi consiglio questo libro per riflettere, e per farvi qualche domanda.
Consigliato a:
gli amanti della prosa novecentesca; coloro ai quali è piaciuto Hamsun o Fante; chi vuole riflettere su libertà e denaro
martedì 26 maggio 2015
mercoledì 20 maggio 2015
"Riparare i viventi", Maylis de Kerangal
Che fare Nicolas? – Seppellire i morti e riparare i viventi.
Tre ragazzi, poco più che ventenni, escono in una fredda mattina di inverno per surfare vicino Le Havre. Al ritorno dalla spiaggia hanno un incidente. Uno dei tre, Simon, ha la peggio. Arrivato in ospedale, viene dichiarato clinicamente morto. Alla famiglia spetterà la decisione più difficile, e cioè se far rivivere Simon attraverso i suoi organi, specialmente il suo cuore.
Queste le premesse di “Riparare i viventi” di Maylis De Kerangal (Feltrinelli). Se pensate che vi abbia spoilerato qualcosa della storia, tranquilli: è abbastanza lineare, e procede senza troppi colpi di scena. Più che una trama, la De Kerangal mira a costruire una serie di sensazioni, di emozioni ritmate dal cuore del protagonista.
A questo punto devo dire che, a dispetto di tutte le recensioni più che lusinghiere a questo libro del 2014, vincitore di alcuni premi in Francia, il mio pollice va decisamente verso il basso. Il passo che sceglie l’autrice è quello di un flusso di prosa, quasi a voler riprendere l’onda tanto cara a Simon. Non sono un amante di questo tipo di scrittura, ma l’apprezzo quando è sostenuta dalla bravura dell’autore, dalle sue scelte lessicali, dalle immagini evocate lungo il cammino. Non è il caso della De Kerangal, secondo il mio parere. Il suo flusso trascina l’attenzione del lettore, sballottolandola a destra e a manca, e, cosa più grave, annegando parole e interi paragrafi. Tanti passaggi vengono sacrificati ad un ritmo che diventa insostenibile, perfino noioso, e rende spesso faticosa la lettura. Puoi evocare un tot di volte, ma poi stanchi davvero. Questo libro finisce per assomigliare ad una storia seria raccontata però da qualcuno che non arriva mai al dunque, e preferisce trucchi e strade laterali alla via principale. Un silenzio, un punto, una frase breve, a volte dicono più di interi discorsi.
Peccato, perchè una storia del genere avrebbe meritato tutto un altro approccio. Era stata quella ad attirarmi, un po’ per le mie esperienze recenti, un po’ perchè si soffermava su qualcosa che spesso diamo per scontato, come il dolore della famiglia e la scelta impossibile che deve fare in una manciata di ore, o di come ci si possa sentire, dall’altra parte, a ricevere qualcosa perchè qualcuno è morto per donartela. Temi forti, importanti, che si perdono in esercizi di stile che strangolano le emozioni, banalizzando gli eventi, i percorsi dei vari protagonisti, e facendo perdere un’occasione per raccontare una buona storia –e, per me, perdere qualche ora del mio tempo.
Consigliato a:
nessuno a cui voglia bene.
Tre ragazzi, poco più che ventenni, escono in una fredda mattina di inverno per surfare vicino Le Havre. Al ritorno dalla spiaggia hanno un incidente. Uno dei tre, Simon, ha la peggio. Arrivato in ospedale, viene dichiarato clinicamente morto. Alla famiglia spetterà la decisione più difficile, e cioè se far rivivere Simon attraverso i suoi organi, specialmente il suo cuore.
Queste le premesse di “Riparare i viventi” di Maylis De Kerangal (Feltrinelli). Se pensate che vi abbia spoilerato qualcosa della storia, tranquilli: è abbastanza lineare, e procede senza troppi colpi di scena. Più che una trama, la De Kerangal mira a costruire una serie di sensazioni, di emozioni ritmate dal cuore del protagonista.
A questo punto devo dire che, a dispetto di tutte le recensioni più che lusinghiere a questo libro del 2014, vincitore di alcuni premi in Francia, il mio pollice va decisamente verso il basso. Il passo che sceglie l’autrice è quello di un flusso di prosa, quasi a voler riprendere l’onda tanto cara a Simon. Non sono un amante di questo tipo di scrittura, ma l’apprezzo quando è sostenuta dalla bravura dell’autore, dalle sue scelte lessicali, dalle immagini evocate lungo il cammino. Non è il caso della De Kerangal, secondo il mio parere. Il suo flusso trascina l’attenzione del lettore, sballottolandola a destra e a manca, e, cosa più grave, annegando parole e interi paragrafi. Tanti passaggi vengono sacrificati ad un ritmo che diventa insostenibile, perfino noioso, e rende spesso faticosa la lettura. Puoi evocare un tot di volte, ma poi stanchi davvero. Questo libro finisce per assomigliare ad una storia seria raccontata però da qualcuno che non arriva mai al dunque, e preferisce trucchi e strade laterali alla via principale. Un silenzio, un punto, una frase breve, a volte dicono più di interi discorsi.
Peccato, perchè una storia del genere avrebbe meritato tutto un altro approccio. Era stata quella ad attirarmi, un po’ per le mie esperienze recenti, un po’ perchè si soffermava su qualcosa che spesso diamo per scontato, come il dolore della famiglia e la scelta impossibile che deve fare in una manciata di ore, o di come ci si possa sentire, dall’altra parte, a ricevere qualcosa perchè qualcuno è morto per donartela. Temi forti, importanti, che si perdono in esercizi di stile che strangolano le emozioni, banalizzando gli eventi, i percorsi dei vari protagonisti, e facendo perdere un’occasione per raccontare una buona storia –e, per me, perdere qualche ora del mio tempo.
Consigliato a:
nessuno a cui voglia bene.
lunedì 18 maggio 2015
"Revival", Stephen King
“Religion is the theological equivalent of a quick-buck insurance scam, where you pay in your premium year after year, and then, when you need the benefits you paid for so—pardon the pun—so religiously, you discover the company that took your money does not, in fact, exist.”
Nei primi anni ’60, Jamie Morton è un ragazzino che gioca con i soldatini davanti casa, in una piccola città del New England. Da lì a poco conoscerà il reverendo Charles Jacobs, il nuovo pastore della congregrazione. Jacobs si dimostra persona affabile, bravo con i bambini, e con un particolare interesse per la scienza, in particolar modo per l’elettricità. Tutto fila liscio finchè un tragico incidente non fa deragliare la vita del reverendo Jacobs dai soliti binari, e lui non è costretto a lasciare la città. Col tempo, Jamie diventa un musicista di una certa fama e, preso dalle sue cose, si dimentica completamente del reverendo Jacobs e dei suoi giochetti con l’elettricità, ignorando che le loro strade sono destinate a incrociarsi nuovamente, e in maniera inaspettata...
“Revival” (Hodder & Stoughton) è un altro prodotto 100% Stephen King, dove, sin dalle prime righe, si può incontrare quello stile che ha affinato con gli anni e con decine e decine di romanzi, e nel quale ormai si muove completamente a proprio agio, e tale fa sentire anche il suo lettore. Il suo modo di scrivere, ormai diventato un classico, è confortevole, rassicurante, nonostante miri a creare suspense e orrore. E in questo “Revival” fallisce, laddove tanti altri romanzi del Re sono riusciti: non si avverte, infatti, quella tensione che poi dovrà sfociare nell’orrore finale, preannunciato già dalle prime pagine (il libro è scritto sotto forma di confessione in prima persona). Da fan di lunga data di King, ho trovato la “preparazione” al finale troppo lunga, sottotono, a volte persino fuori traccia. Al confronto, il finale è troppo breve, e non molto sorprendente.
Quello di King è un omaggio ai grandi scrittori horror classici, da Mary Shelley a Lovecraft, e questo si avverte sia nella tematica scelta che in alcune scelte stilistiche –giustificando (parzialmente) la macchinosità di alcuni passaggi.
King è soprattutto un ottimo storyteller, anzi uno dei migliori assoluti in circolazione. E’ bravo a creare atmosfere credibili e personaggi realistici, nei quali i lettori riescono ad identificarsi. Il suo trucchetto, per creare personaggi per cui fare il tifo, sta nel mostrare impietosamente le loro debolezze: anche in “Revival”, è la dipendenza da eroina di Jamie a farcelo vedere più umano, e farcelo piacere ancora di più. Il rapporto di Jamie con i familiari, il suo amore adolescenziale, tutto è descritto con la mano esperta di chi sa il fatto suo quando si tratta di raccontare storie. Per non parlare della parte “musicale” della storia, che mostra ancora una volta la passione che il Re ha sempre nutrito per il rock.
La parte che mi ha attirato di più di “Revival” è quella legata alle domande che solleva. King ha esaminato già in altri libri il suo rapporto con Dio e con la fede. Alcuni dei suoi romanzi sono più positivi rispetto alla religione, altri no. “Revival” cade decisamente nella seconda categoria. Nonostante i toni leggeri con cui si apre, è un libro cupo, dal finale disperato. Alla bocca del reverendo Jacobs sono affidati i dubbi su Dio. Esiste? Come facciamo ad esserne così sicuri? E quando ci succede qualcosa di terribile, possiamo continuare a credere, come se niente fosse successo? La crudeltà rientra nel disegno divino, o siamo noi umani che vogliamo a tutti i costi trovare una giustificazione al dolore?
La gente ha bisogno di miracoli, dice ad un certo punto il reverendo Jacobs, per non dover pensare che la vita sia solo un passaggio dalla culla alla tomba. Per poter credere che ci sia qualcos’altro.
Cos’è, allora, questo “qualcos’altro”? Se foste messi in condizione di poterlo scoprire PRIMA di morire, lo fareste?
Per tutti questi motivi, “Revival” è un libro interessante, anche se decisamente non uno dei migliori del Re, e che potrebbe lasciarvi un po’ di amaro in bocca alla fine.
Consigliato a:
i fan del Re; gli appassionati dei racconti di Poe, Shelley, Lovecraft; chi desidera un libro scorrevole e non ha troppa fretta.
Nei primi anni ’60, Jamie Morton è un ragazzino che gioca con i soldatini davanti casa, in una piccola città del New England. Da lì a poco conoscerà il reverendo Charles Jacobs, il nuovo pastore della congregrazione. Jacobs si dimostra persona affabile, bravo con i bambini, e con un particolare interesse per la scienza, in particolar modo per l’elettricità. Tutto fila liscio finchè un tragico incidente non fa deragliare la vita del reverendo Jacobs dai soliti binari, e lui non è costretto a lasciare la città. Col tempo, Jamie diventa un musicista di una certa fama e, preso dalle sue cose, si dimentica completamente del reverendo Jacobs e dei suoi giochetti con l’elettricità, ignorando che le loro strade sono destinate a incrociarsi nuovamente, e in maniera inaspettata...
“Revival” (Hodder & Stoughton) è un altro prodotto 100% Stephen King, dove, sin dalle prime righe, si può incontrare quello stile che ha affinato con gli anni e con decine e decine di romanzi, e nel quale ormai si muove completamente a proprio agio, e tale fa sentire anche il suo lettore. Il suo modo di scrivere, ormai diventato un classico, è confortevole, rassicurante, nonostante miri a creare suspense e orrore. E in questo “Revival” fallisce, laddove tanti altri romanzi del Re sono riusciti: non si avverte, infatti, quella tensione che poi dovrà sfociare nell’orrore finale, preannunciato già dalle prime pagine (il libro è scritto sotto forma di confessione in prima persona). Da fan di lunga data di King, ho trovato la “preparazione” al finale troppo lunga, sottotono, a volte persino fuori traccia. Al confronto, il finale è troppo breve, e non molto sorprendente.
Quello di King è un omaggio ai grandi scrittori horror classici, da Mary Shelley a Lovecraft, e questo si avverte sia nella tematica scelta che in alcune scelte stilistiche –giustificando (parzialmente) la macchinosità di alcuni passaggi.
King è soprattutto un ottimo storyteller, anzi uno dei migliori assoluti in circolazione. E’ bravo a creare atmosfere credibili e personaggi realistici, nei quali i lettori riescono ad identificarsi. Il suo trucchetto, per creare personaggi per cui fare il tifo, sta nel mostrare impietosamente le loro debolezze: anche in “Revival”, è la dipendenza da eroina di Jamie a farcelo vedere più umano, e farcelo piacere ancora di più. Il rapporto di Jamie con i familiari, il suo amore adolescenziale, tutto è descritto con la mano esperta di chi sa il fatto suo quando si tratta di raccontare storie. Per non parlare della parte “musicale” della storia, che mostra ancora una volta la passione che il Re ha sempre nutrito per il rock.
La parte che mi ha attirato di più di “Revival” è quella legata alle domande che solleva. King ha esaminato già in altri libri il suo rapporto con Dio e con la fede. Alcuni dei suoi romanzi sono più positivi rispetto alla religione, altri no. “Revival” cade decisamente nella seconda categoria. Nonostante i toni leggeri con cui si apre, è un libro cupo, dal finale disperato. Alla bocca del reverendo Jacobs sono affidati i dubbi su Dio. Esiste? Come facciamo ad esserne così sicuri? E quando ci succede qualcosa di terribile, possiamo continuare a credere, come se niente fosse successo? La crudeltà rientra nel disegno divino, o siamo noi umani che vogliamo a tutti i costi trovare una giustificazione al dolore?
La gente ha bisogno di miracoli, dice ad un certo punto il reverendo Jacobs, per non dover pensare che la vita sia solo un passaggio dalla culla alla tomba. Per poter credere che ci sia qualcos’altro.
Cos’è, allora, questo “qualcos’altro”? Se foste messi in condizione di poterlo scoprire PRIMA di morire, lo fareste?
Per tutti questi motivi, “Revival” è un libro interessante, anche se decisamente non uno dei migliori del Re, e che potrebbe lasciarvi un po’ di amaro in bocca alla fine.
Consigliato a:
i fan del Re; gli appassionati dei racconti di Poe, Shelley, Lovecraft; chi desidera un libro scorrevole e non ha troppa fretta.
lunedì 4 maggio 2015
Di nebbie, scadenze, Case Gialle e pezzi di felicita'
Quando ti trovi a dover aspettare l’esito, potenzialmente negativo, di qualcosa, cominci inconsciamente ad escludere alcune parole e associazioni dalla tua mente. Almeno, io faccio così. È il mio solito pilota automatico, che entra in funziona non appena si alza la nebbia (una più spessa del solito, in ogni caso) e non si riesce più a distinguere bene quello che c’è davanti. A quel punto, ci sono solo due scelte: o bloccarsi ed aspettare che la nebbia passi, o tirare dritto con quello che si ha, contando, di volta in volta, sull’istinto, sulla forza, sulla rabbia, sull’inerzia, sulla pura e semplice volontà di non farsi bloccare da quella nebbia.
Non è percorso facile, e varia completamente da persona a persona. Ovvio, direte voi. Eppure niente sembra ovvio in quei momenti. Le certezze sono le prime a svignarsela, e questo la dice lunga sulla natura di tali certezze. Puoi contare su di te, certo: ma questo, esattamente, cosa vuol dire?
Vuol dire tirar fuori quello che si ha, senza stare lì a sottilizzare se si tratti di cuore, coglioni, fegato, cervello, culo. Soprattutto, provare a farlo in maniera attiva. In questi casi, non c’è cosa peggiore che sedersi e sentirsi vittime dell’universo.
Soprattutto perchè, in queste situazioni, lo siete davvero.
C’è gente che pensa che io sappia mostrare le palle al momento opportuno, perchè ne ho passata qualcuna e sono riuscito più o meno a riderne. Io invece guardo a chi ha passato roba peggiore, a chi ancora la passa, penso al modo in cui lo fa, e non posso che sentirmi minuscolo. Ci sono dei giganti là fuori, ragazzi. Se avete la fortuna di conoscerne qualcuno, sapete di cosa sto parlando. Storie che non vengono pubblicizzate, di cui non si sa niente, e per cui quella parola tanto sputtanata come “eroe”, a volte sembra anche riduttiva. Portano avanti battaglie che noi abbiamo dimenticato, delegato, messo da parte: quelle per il semplice diritto a vivere.
Anch’io che, come detto, ne ho passata qualcuna, l’ho dimenticato. Una volta passata la nebbia, uno non ci vuole più pensare, giusto? Ormai è andata, tanto. Ce l’hai fatta. Se sarai fortunato, riuscirai a trasportare il peso e la luce di un’esperienza del genere nella vita di tutti i giorni, fino a capire che non esiste affatto, la “vita di tutti i giorni”, ma è solo un’espressione del cazzo che trasuda fine, oblio e rimandare. Esiste solo la vita, bella o brutta, non ci sono cazzi.
Ma posso capire perchè sembri troppa da mandare giù tutta assieme, e perchè molti di noi preferiscano annacquarla, prendendola a piccole dosi, scomponendola in progetti e date e vacanze.
Anch’io ho fatto così.
Uscito dalla nebbia, ho fatto in modo di dimenticarmene (sperando che lei si dimenticasse di me, forse), e mi sono anch’io immerso nella “vita di tutti i giorni”. Ho ripreso ad incazzarmi se quello davanti a me non scattava quando il semaforo diventava verde, a sbuffare se pioveva ed ero uscito semza ombrello, a prendermela se al lavoro le cose giravano in un altro modo.
In fondo, tutto ciò è solo umano. A furia di fissare la vita nella sua interezza, ogni giorno e ogni ora, ci verrebbe il mal di testa più grande del mondo. Solo poche persone probabilmente sono in grado di farlo, e si dividono tra santi, pazzi, poeti, bambini, innamorati, intossicati. Gli altri devono spezzettarla e poi “tagliarla” con altro per poterla inalare o mandare giù. Questo “altro” varia per ognuno –dalla squadra di calcio alla propria perversione sessuale, ai soldi, al cibo, al gioco, alle droghe e così via- ma ognuno ha il suo. Ci rende sopportabile la vita, ci aiuta a concentrarci sull’attimo senza dover costantemente guardare avanti e indietro. Ha senso, perchè ci evita di fondere come calcolatori spremuti a sangue, con troppe informazioni da analizzare tutte insieme.
E allora strepitiamo e ci incazziamo per le stupidaggini, ma a volte riusciamo a godere di cose altrettanto piccole che, per un attimo, ci mandano in vena dei frammenti di eternità.
Un modo per far quadrare i conti.
C’è però un prezzo da pagare.
Dimenticarsi la nebbia, concentrarci sul momento, ci fa dimenticare una cosuccia molto fastidiosa, ma anche abbastanza importante: non siamo qui per sempre.
Le so le facce che state facendo. Però è vero, e lo sapete. Non importa nemmeno la vostra età. Direste che un sessantenne tende a pensarci più di un ventenne, ma questo non è necessariamente vero. Viviamo in un oblìo voluto, auto-indotto, che ci aiuti a tirare avanti senza patemi e senza troppe pressioni.
Prendiamo tempo. Esiste cosa più umana?
Ma rimandiamo, anche, e accampiamo scuse, ci inventiamo ostacoli, esageriamo quelli esistenti, ci paralizziamo in una rassicurante realtà. Anche queste sono cose umane, e in qualche circostanza anche più che giustificabili.
Ma quando le mettiamo accanto a quella verità lì, perdono tutto il loro potere. Quando ci ricordiamo che il tempo a disposizione è limitato, allora quel tempo diventa prezioso, così come prezioso diventa l’uso che ne facciamo.
Per questo la nebbia, che si insinua nella nostra esistenza avvolgendo tutto ciò che ritenevamo importante, ha, in mezzo allo sfacelo che crea, anche una valenza positiva: ci mette a contatto con la nostra limitatezza. Ci ricorda che, seppure viviamo più a lungo e con più coscienza (e autocoscienza) di un albero o di un pesce rosso, finiremo anche noi di esistere come loro –quantomeno in forma fisica. Ci ricorda che possiamo circondarci di tutte le stronzate del mondo, ma questo non fa di noi degli immortali. Ci ricorda che possiamo perderci nelle nostre mille piccole battaglie quotidiane, ma dall’ultima non ne usciremo comunque vivi. Ci ricorda che dobbiamo godercela di più, che dobbiamo vivere di più, ma che forse è anche arrivato il momento di finire quello che si è iniziato.
Da qualche mese ho iniziato, insieme ad altri amici, un progetto che si chiama “Yellow House”. Vi rimando al sito (che trovate qui) per i dettagli. Era un po’ che avevo in mente una cosa del genere, e ovviamente continuavo a rimandare al “momento migliore” (che credo non esista mai, in nessuna situazione). Dopo la mia ultima nebbia, ho deciso di agire. Abbiamo cominciato, tra difficoltà, diffidenza, discorsi a vuoto e incertezze. L’idea di fondo nasceva anche dalla nebbia: siamo circondati da persone che hanno talento, che sono creative, ma per ragioni pratiche o altro, hanno messo da parte quello che gli riesce meglio, aspettando il “momento migliore” (arieccolo). In questa grande Casa virtuale, volevamo essere ognuno uno stimolo per l’altro, uno sprone a fare. Come a volerci ricordare l’un l’altro che il tempo che ci resta può essere poco o tantissimo, e per questo dobbiamo farne buon uso. Senza più rimandare, senza più lasciar perdere.
Abbiamo cominciato, con la “Yellow House”, e non finiremo presto –tempo permettendo.
Volevo mettere nero su bianco queste sensazioni. Sapete perchè?
Perchè domani me ne sarò già scordato. Domani sarò forse tornato anch’io a prendermela se l’autobus è in ritardo o se la batteria del telefono è già scarica. Sarò tornato a “tagliare” la mia vita con tutto quello che mi permetta di annacquarla, e di dimenticarne i limiti.
Domani, forse.
Stasera però lo so benissimo, che il tempo è prezioso. Io voglio usarlo, adesso, per scrivere tutto questo –per voi, ma soprattutto per me- e per alzare la mia birra qui accanto e brindare insieme a voi.
Perchè oggi sono uscito dalla nebbia.
Perchè oggi sono felice.
Perchè oggi sono qui e non altrove. Perchè oggi non ho scuse e non le voglio.
Perchè oggi è il primo giorno.
Domani, si vedrà.
Alla vostra e un po’ anche alla mia,
Zango
Non è percorso facile, e varia completamente da persona a persona. Ovvio, direte voi. Eppure niente sembra ovvio in quei momenti. Le certezze sono le prime a svignarsela, e questo la dice lunga sulla natura di tali certezze. Puoi contare su di te, certo: ma questo, esattamente, cosa vuol dire?
Vuol dire tirar fuori quello che si ha, senza stare lì a sottilizzare se si tratti di cuore, coglioni, fegato, cervello, culo. Soprattutto, provare a farlo in maniera attiva. In questi casi, non c’è cosa peggiore che sedersi e sentirsi vittime dell’universo.
Soprattutto perchè, in queste situazioni, lo siete davvero.
C’è gente che pensa che io sappia mostrare le palle al momento opportuno, perchè ne ho passata qualcuna e sono riuscito più o meno a riderne. Io invece guardo a chi ha passato roba peggiore, a chi ancora la passa, penso al modo in cui lo fa, e non posso che sentirmi minuscolo. Ci sono dei giganti là fuori, ragazzi. Se avete la fortuna di conoscerne qualcuno, sapete di cosa sto parlando. Storie che non vengono pubblicizzate, di cui non si sa niente, e per cui quella parola tanto sputtanata come “eroe”, a volte sembra anche riduttiva. Portano avanti battaglie che noi abbiamo dimenticato, delegato, messo da parte: quelle per il semplice diritto a vivere.
Anch’io che, come detto, ne ho passata qualcuna, l’ho dimenticato. Una volta passata la nebbia, uno non ci vuole più pensare, giusto? Ormai è andata, tanto. Ce l’hai fatta. Se sarai fortunato, riuscirai a trasportare il peso e la luce di un’esperienza del genere nella vita di tutti i giorni, fino a capire che non esiste affatto, la “vita di tutti i giorni”, ma è solo un’espressione del cazzo che trasuda fine, oblio e rimandare. Esiste solo la vita, bella o brutta, non ci sono cazzi.
Ma posso capire perchè sembri troppa da mandare giù tutta assieme, e perchè molti di noi preferiscano annacquarla, prendendola a piccole dosi, scomponendola in progetti e date e vacanze.
Anch’io ho fatto così.
Uscito dalla nebbia, ho fatto in modo di dimenticarmene (sperando che lei si dimenticasse di me, forse), e mi sono anch’io immerso nella “vita di tutti i giorni”. Ho ripreso ad incazzarmi se quello davanti a me non scattava quando il semaforo diventava verde, a sbuffare se pioveva ed ero uscito semza ombrello, a prendermela se al lavoro le cose giravano in un altro modo.
In fondo, tutto ciò è solo umano. A furia di fissare la vita nella sua interezza, ogni giorno e ogni ora, ci verrebbe il mal di testa più grande del mondo. Solo poche persone probabilmente sono in grado di farlo, e si dividono tra santi, pazzi, poeti, bambini, innamorati, intossicati. Gli altri devono spezzettarla e poi “tagliarla” con altro per poterla inalare o mandare giù. Questo “altro” varia per ognuno –dalla squadra di calcio alla propria perversione sessuale, ai soldi, al cibo, al gioco, alle droghe e così via- ma ognuno ha il suo. Ci rende sopportabile la vita, ci aiuta a concentrarci sull’attimo senza dover costantemente guardare avanti e indietro. Ha senso, perchè ci evita di fondere come calcolatori spremuti a sangue, con troppe informazioni da analizzare tutte insieme.
E allora strepitiamo e ci incazziamo per le stupidaggini, ma a volte riusciamo a godere di cose altrettanto piccole che, per un attimo, ci mandano in vena dei frammenti di eternità.
Un modo per far quadrare i conti.
C’è però un prezzo da pagare.
Dimenticarsi la nebbia, concentrarci sul momento, ci fa dimenticare una cosuccia molto fastidiosa, ma anche abbastanza importante: non siamo qui per sempre.
Le so le facce che state facendo. Però è vero, e lo sapete. Non importa nemmeno la vostra età. Direste che un sessantenne tende a pensarci più di un ventenne, ma questo non è necessariamente vero. Viviamo in un oblìo voluto, auto-indotto, che ci aiuti a tirare avanti senza patemi e senza troppe pressioni.
Prendiamo tempo. Esiste cosa più umana?
Ma rimandiamo, anche, e accampiamo scuse, ci inventiamo ostacoli, esageriamo quelli esistenti, ci paralizziamo in una rassicurante realtà. Anche queste sono cose umane, e in qualche circostanza anche più che giustificabili.
Ma quando le mettiamo accanto a quella verità lì, perdono tutto il loro potere. Quando ci ricordiamo che il tempo a disposizione è limitato, allora quel tempo diventa prezioso, così come prezioso diventa l’uso che ne facciamo.
Per questo la nebbia, che si insinua nella nostra esistenza avvolgendo tutto ciò che ritenevamo importante, ha, in mezzo allo sfacelo che crea, anche una valenza positiva: ci mette a contatto con la nostra limitatezza. Ci ricorda che, seppure viviamo più a lungo e con più coscienza (e autocoscienza) di un albero o di un pesce rosso, finiremo anche noi di esistere come loro –quantomeno in forma fisica. Ci ricorda che possiamo circondarci di tutte le stronzate del mondo, ma questo non fa di noi degli immortali. Ci ricorda che possiamo perderci nelle nostre mille piccole battaglie quotidiane, ma dall’ultima non ne usciremo comunque vivi. Ci ricorda che dobbiamo godercela di più, che dobbiamo vivere di più, ma che forse è anche arrivato il momento di finire quello che si è iniziato.
Da qualche mese ho iniziato, insieme ad altri amici, un progetto che si chiama “Yellow House”. Vi rimando al sito (che trovate qui) per i dettagli. Era un po’ che avevo in mente una cosa del genere, e ovviamente continuavo a rimandare al “momento migliore” (che credo non esista mai, in nessuna situazione). Dopo la mia ultima nebbia, ho deciso di agire. Abbiamo cominciato, tra difficoltà, diffidenza, discorsi a vuoto e incertezze. L’idea di fondo nasceva anche dalla nebbia: siamo circondati da persone che hanno talento, che sono creative, ma per ragioni pratiche o altro, hanno messo da parte quello che gli riesce meglio, aspettando il “momento migliore” (arieccolo). In questa grande Casa virtuale, volevamo essere ognuno uno stimolo per l’altro, uno sprone a fare. Come a volerci ricordare l’un l’altro che il tempo che ci resta può essere poco o tantissimo, e per questo dobbiamo farne buon uso. Senza più rimandare, senza più lasciar perdere.
Abbiamo cominciato, con la “Yellow House”, e non finiremo presto –tempo permettendo.
Volevo mettere nero su bianco queste sensazioni. Sapete perchè?
Perchè domani me ne sarò già scordato. Domani sarò forse tornato anch’io a prendermela se l’autobus è in ritardo o se la batteria del telefono è già scarica. Sarò tornato a “tagliare” la mia vita con tutto quello che mi permetta di annacquarla, e di dimenticarne i limiti.
Domani, forse.
Stasera però lo so benissimo, che il tempo è prezioso. Io voglio usarlo, adesso, per scrivere tutto questo –per voi, ma soprattutto per me- e per alzare la mia birra qui accanto e brindare insieme a voi.
Perchè oggi sono uscito dalla nebbia.
Perchè oggi sono felice.
Perchè oggi sono qui e non altrove. Perchè oggi non ho scuse e non le voglio.
Perchè oggi è il primo giorno.
Domani, si vedrà.
Alla vostra e un po’ anche alla mia,
Zango
Iscriviti a:
Commenti (Atom)